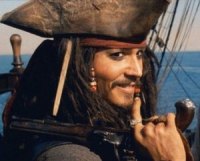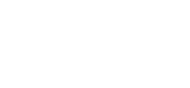stdClass Object
(
[id] => 10275
[title] => I limiti della Troika
[alias] => i-limiti-della-troika
[introtext] => Non esiste un solo modo di fare economia o impresa: il modello usa non è adatto al vecchio continente. Finanza e politica non sono la stessa cosa
di Luigino Bruni
pubblicato su Città Nuova n.03/2015 del 10/02/2015
 Dovremmo prendere molto sul serio l’ondata di malessere nei confronti delle istituzioni finanziarie europee e mondiali (la Troika) che sale con sempre maggior forza dalla Grecia, dalla Spagna, dal Portogallo, ma anche dalla Francia e dall’Italia. Dall’Europa latina, comunitaria, ‘cattolica’ (e ortodossa). Sono evidentemente molte, e non tutte buone, le ragioni nascoste dietro le proteste nei confronti della politica Europea e dell’euro. Ma c’è anche qualcosa di profondo e di molto serio.
Dovremmo prendere molto sul serio l’ondata di malessere nei confronti delle istituzioni finanziarie europee e mondiali (la Troika) che sale con sempre maggior forza dalla Grecia, dalla Spagna, dal Portogallo, ma anche dalla Francia e dall’Italia. Dall’Europa latina, comunitaria, ‘cattolica’ (e ortodossa). Sono evidentemente molte, e non tutte buone, le ragioni nascoste dietro le proteste nei confronti della politica Europea e dell’euro. Ma c’è anche qualcosa di profondo e di molto serio.
[fulltext] =>
Le economie e i capitalismi nel mondo non sono mai stati tutti uguali. Fino agli anni settanta del secolo scorso, i sistemi economici nel mondo erano molti e diversi. C’era il capitalismo USA, ma anche quello tedesco, francese, l’economia mista e popolare italiana, ancora l’economia socialista, i diversi ‘capitalismi’ giapponesi, indiani, sudamericani … Questa varietà di vie al mercato e all’economia aveva dato vita anche ad una grande biodiversità nelle forme di impresa e di banca, nel mondo di lavorare, di produrre, di consumare. Di vivere: l’economia non è né più né meno della vita della gente. Con l’inizio della globalizzazione dei mercati, accompagnato da una stagione di pensiero della cosiddetta ideologia neo-liberista (che io chiamerei post- o ultra-liberista), ha preso il via un processo di convergenza dei vari ‘capitalismi’ verso il modello USA, con una forte riduzione delle differenze nazionali e del genius loci dei singoli popoli, un appiattimento culturale e una forte perdita di biodiversità. Si è così iniziato a pensare che ci fosse una sola buona cultura di impresa, una sola banca efficiente, un solo modo di fare finanza; e tutte le altre forme di economia, impresa, banche diverse e lontane da questa unica idea buona e vera, erano considerate attriti e residui di un passato feudale che doveva essere eliminato presto. Un ruolo fondamentale in questo avanzare incontrastato dell’ideologia dell’unica via al capitalismo lo hanno svolto, e lo svolgono, le scuole di impresa nel mondo, che stanno producendo e implementando una ideologia manageriale ‘universale’, insegnando in tutto il mondo. Nelle business school di Buea e di Chicago si seguono ormai gli stessi ‘protocolli’ (come in chirurgia) poiché l’impresa è una, ha le stesse regole in tutto il mondo. Poco conta se quelle imprese poi si troveranno ad operare negli slum di Nairobi o nella city di Londra. Stesso discorso per le banche e per la finanza.
In realtà le cose stanno molto diversamente. L’economia europea ha sempre avuto più anime economiche, più ‘spiriti del capitalismo’. In particolare la Riforma protestante ha dato vita ad una cultura d’impresa e di banca diversa da quella che è rimasta ed è continuata ad operare nei paesi a cultura cattolica (e ancor più ortodossa). La netta separazione tra dono e contratto, tra comunità e impresa che si è affermata nei paesi del nord Europa e negli USA (in seguito, anche, alla reazione di Lutero ad un intreccio troppo stretto e in buona parte sbagliato tra denaro e dono: il ‘mercato delle indulgenze’), non si è mai operata nei paesi mediterranei. Da noi l’economia è rimasta mescolata con la comunità, il dono con i contratti, il denaro con la gratuità, un intreccio che ha generato molte malattie tipiche di questi paesi (dalle mafie al familismo), ma ha prodotto anche alcune benedizioni. Tra quest’ultime le imprese famigliari (ancora oggi il cuore pulsante dell’economia italiana), il grande movimento cooperativo, le casse rurali e di risparmio, le BCC, le banche popolari, che hanno fatto ricca, equa e bella la nostra economia.
La creazione dell’Europa pose il ‘principio di sussidiarietà’ come sua pietra angolare (il primo potere ce l’hanno i soggetti vicini al problema da risolvere). Ma ci siamo limitati ad applicarlo alla sfera politico-amministrativa (nell’ordinare le competenze tra istituzioni europee, nazionali, regionali, locali), mentre a livello finanziario ed economico si sta sempre più applicando l’anti-sussidiarietà. Infatti, la finanza si è via via concentrata attorno a Francoforte, svuotando di potere le banche centrali nazionali, e le direttive europee sulle dimensioni ottime delle banche commerciali stanno producendo gruppi bancari sempre più grandi e lontani dai territori. Mentre l’Europa politica procede dall’alto verso il basso, l’Europa della finanza si muove nella direzione opposta, allontanando le decisioni dalle persone e dai territori. In questo contesto si capisce la gravità del decreto del Governo Renzi che ha di fatto trasformato le banche popolari (beni pubblici e antica eredità dell’umanesimo comunitario italiano) in società per azioni, in società anonime: beni comuni in beni privati di pochi.
L’Europa potrà realizzare il grande sogno dei suoi padri se allargherà il campo di azione del principio di sussidiarietà a tutti gli ambiti. Oggi non è solo urgente riavvicinare le istituzioni finanziarie ed economiche ai territori, ma è anche indispensabile ricordare che l’economia è penultima parola, mai l’ultima: non sono le ragioni della politica (Bene comune) che devono servire quelle dell’economia (beni privati), ma viceversa. Dietro il grido dei Paesi mediterranei in crisi dobbiamo allora sapere ascoltare anche la domanda di identità, di biodiversità, di storia.
Reimpariamo ad ascoltare il grido dei poveri: in esso si nasconde sempre un portato di verità e di Bene comune di cui l’Europa non può e non deve fare a meno.
[checked_out] => 0
[checked_out_time] => 0000-00-00 00:00:00
[catid] => 890
[created] => 2015-03-13 10:31:25
[created_by] => 64
[created_by_alias] => Luigino Bruni
[state] => 1
[modified] => 2020-10-14 14:37:16
[modified_by] => 2025
[modified_by_name] => Maria Rosa Logozzo
[publish_up] => 2015-03-13 10:31:25
[publish_down] => 0000-00-00 00:00:00
[images] => {"image_intro":"","float_intro":"","image_intro_alt":"","image_intro_caption":"","image_fulltext":"","float_fulltext":"","image_fulltext_alt":"","image_fulltext_caption":""}
[urls] => {"urla":false,"urlatext":"","targeta":"","urlb":false,"urlbtext":"","targetb":"","urlc":false,"urlctext":"","targetc":""}
[attribs] => {"article_layout":"","show_title":"","link_titles":"","show_tags":"","show_intro":"","info_block_position":"","info_block_show_title":"","show_category":"","link_category":"","show_parent_category":"","link_parent_category":"","show_associations":"","show_author":"","link_author":"","show_create_date":"","show_modify_date":"","show_publish_date":"","show_item_navigation":"","show_icons":"","show_print_icon":"","show_email_icon":"","show_vote":"","show_hits":"","show_noauth":"","urls_position":"","alternative_readmore":"","article_page_title":"","show_publishing_options":"","show_article_options":"","show_urls_images_backend":"","show_urls_images_frontend":"","helix_ultimate_image":"","helix_ultimate_image_alt_txt":"","helix_ultimate_article_format":"standard","helix_ultimate_audio":"","helix_ultimate_gallery":"","helix_ultimate_video":""}
[metadata] => {"robots":"","author":"","rights":"","xreference":""}
[metakey] =>
[metadesc] =>
[access] => 1
[hits] => 2816
[xreference] =>
[featured] => 0
[language] => it-IT
[on_img_default] => 1
[readmore] => 5114
[ordering] => 100
[category_title] => IT - CN
[category_route] => economia-civile/it-editoriali-vari/it-cn
[category_access] => 1
[category_alias] => it-cn
[published] => 1
[parents_published] => 1
[lft] => 81
[author] => Luigino Bruni
[author_email] => ferrucci.anto@gmail.com
[parent_title] => IT - Editoriali vari
[parent_id] => 893
[parent_route] => economia-civile/it-editoriali-vari
[parent_alias] => it-editoriali-vari
[rating] => 0
[rating_count] => 0
[alternative_readmore] =>
[layout] =>
[params] => Joomla\Registry\Registry Object
(
[data:protected] => stdClass Object
(
[article_layout] => _:default
[show_title] => 1
[link_titles] => 1
[show_intro] => 1
[info_block_position] => 0
[info_block_show_title] => 1
[show_category] => 1
[link_category] => 1
[show_parent_category] => 1
[link_parent_category] => 1
[show_associations] => 0
[flags] => 1
[show_author] => 0
[link_author] => 0
[show_create_date] => 1
[show_modify_date] => 0
[show_publish_date] => 1
[show_item_navigation] => 1
[show_vote] => 0
[show_readmore] => 0
[show_readmore_title] => 0
[readmore_limit] => 100
[show_tags] => 1
[show_icons] => 1
[show_print_icon] => 1
[show_email_icon] => 1
[show_hits] => 0
[record_hits] => 1
[show_noauth] => 0
[urls_position] => 1
[captcha] =>
[show_publishing_options] => 1
[show_article_options] => 1
[save_history] => 1
[history_limit] => 10
[show_urls_images_frontend] => 0
[show_urls_images_backend] => 1
[targeta] => 0
[targetb] => 0
[targetc] => 0
[float_intro] => left
[float_fulltext] => left
[category_layout] => _:blog
[show_category_heading_title_text] => 0
[show_category_title] => 0
[show_description] => 0
[show_description_image] => 0
[maxLevel] => 0
[show_empty_categories] => 0
[show_no_articles] => 1
[show_subcat_desc] => 0
[show_cat_num_articles] => 0
[show_cat_tags] => 1
[show_base_description] => 1
[maxLevelcat] => -1
[show_empty_categories_cat] => 0
[show_subcat_desc_cat] => 0
[show_cat_num_articles_cat] => 0
[num_leading_articles] => 0
[num_intro_articles] => 14
[num_columns] => 2
[num_links] => 0
[multi_column_order] => 1
[show_subcategory_content] => -1
[show_pagination_limit] => 1
[filter_field] => hide
[show_headings] => 1
[list_show_date] => 0
[date_format] =>
[list_show_hits] => 1
[list_show_author] => 1
[list_show_votes] => 0
[list_show_ratings] => 0
[orderby_pri] => none
[orderby_sec] => rdate
[order_date] => published
[show_pagination] => 2
[show_pagination_results] => 1
[show_featured] => show
[show_feed_link] => 1
[feed_summary] => 0
[feed_show_readmore] => 0
[sef_advanced] => 1
[sef_ids] => 1
[custom_fields_enable] => 1
[show_page_heading] => 0
[layout_type] => blog
[menu_text] => 1
[menu_show] => 1
[secure] => 0
[helixultimatemenulayout] => {"width":600,"menualign":"right","megamenu":0,"showtitle":1,"faicon":"","customclass":"","dropdown":"right","badge":"","badge_position":"","badge_bg_color":"","badge_text_color":"","layout":[]}
[helixultimate_enable_page_title] => 1
[helixultimate_page_title_alt] => Economia Civile
[helixultimate_page_subtitle] => Città Nuova
[helixultimate_page_title_heading] => h2
[page_title] => Città Nuova
[page_description] =>
[page_rights] =>
[robots] =>
[access-view] => 1
)
[initialized:protected] => 1
[separator] => .
)
[displayDate] => 2015-03-13 10:31:25
[tags] => Joomla\CMS\Helper\TagsHelper Object
(
[tagsChanged:protected] =>
[replaceTags:protected] =>
[typeAlias] =>
[itemTags] => Array
(
)
)
[slug] => 10275:i-limiti-della-troika
[parent_slug] => 893:it-editoriali-vari
[catslug] => 890:it-cn
[event] => stdClass Object
(
[afterDisplayTitle] =>
[beforeDisplayContent] =>
[afterDisplayContent] =>
)
[text] => Non esiste un solo modo di fare economia o impresa: il modello usa non è adatto al vecchio continente. Finanza e politica non sono la stessa cosa
di Luigino Bruni
pubblicato su Città Nuova n.03/2015 del 10/02/2015
 Dovremmo prendere molto sul serio l’ondata di malessere nei confronti delle istituzioni finanziarie europee e mondiali (la Troika) che sale con sempre maggior forza dalla Grecia, dalla Spagna, dal Portogallo, ma anche dalla Francia e dall’Italia. Dall’Europa latina, comunitaria, ‘cattolica’ (e ortodossa). Sono evidentemente molte, e non tutte buone, le ragioni nascoste dietro le proteste nei confronti della politica Europea e dell’euro. Ma c’è anche qualcosa di profondo e di molto serio.
Dovremmo prendere molto sul serio l’ondata di malessere nei confronti delle istituzioni finanziarie europee e mondiali (la Troika) che sale con sempre maggior forza dalla Grecia, dalla Spagna, dal Portogallo, ma anche dalla Francia e dall’Italia. Dall’Europa latina, comunitaria, ‘cattolica’ (e ortodossa). Sono evidentemente molte, e non tutte buone, le ragioni nascoste dietro le proteste nei confronti della politica Europea e dell’euro. Ma c’è anche qualcosa di profondo e di molto serio.
[jcfields] => Array
(
)
[type] => intro
[oddeven] => item-odd
)






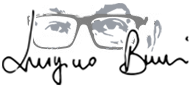
 Mi trovavo a Londra a completare i miei studi di economia, quando la mattina dell’8 maggio del 1998 mi telefona a casa Chiara Lubich. Anche se facevo parte del suo movimento da quando avevo 15 anni – è la grande avventura della mia vita – non avevo mai parlato personalmente con lei. Ricordo ancora l’emozione e la sorpresa, ma soprattutto ricordo bene le sue parole: “Mi vuoi aiutare per dare dignità scientifica all’Economia di comunione?”. E poi aggiunse che tornando in Brasile dopo sette anni dal lancio dell’EdC aveva capito che se accanto agli imprenditori non si fosse sviluppato anche un pensiero economico, l’EdC non sarebbe decollata. Io risposi di sì, venni da Londra a Roma, e iniziai a collaborare con lei e tanti altri compagni-e per contribuire a dare un po’ di questa dignità scientifica alla vita che c’era e che c’è. E capii che la vita ha la priorità, ma anche il pensiero e la teoria sono vita, e quando mancano rendono la prassi povera e di corto respiro.
Mi trovavo a Londra a completare i miei studi di economia, quando la mattina dell’8 maggio del 1998 mi telefona a casa Chiara Lubich. Anche se facevo parte del suo movimento da quando avevo 15 anni – è la grande avventura della mia vita – non avevo mai parlato personalmente con lei. Ricordo ancora l’emozione e la sorpresa, ma soprattutto ricordo bene le sue parole: “Mi vuoi aiutare per dare dignità scientifica all’Economia di comunione?”. E poi aggiunse che tornando in Brasile dopo sette anni dal lancio dell’EdC aveva capito che se accanto agli imprenditori non si fosse sviluppato anche un pensiero economico, l’EdC non sarebbe decollata. Io risposi di sì, venni da Londra a Roma, e iniziai a collaborare con lei e tanti altri compagni-e per contribuire a dare un po’ di questa dignità scientifica alla vita che c’era e che c’è. E capii che la vita ha la priorità, ma anche il pensiero e la teoria sono vita, e quando mancano rendono la prassi povera e di corto respiro. Tornando da Parigi da una scuola estiva sull’Economia di Comunione, volando sui cieli d’Europa penso al nostro capitalismo. Forse perché in Francia è appena cambiato il ministro dell’economia, forse perché ho appena salutato cinquanta giovani affascinati da un’economia più fraterna e inclusiva, o perché il cuore va ai troppi aerei sbagliati che volano sulle tante terre martoriate dalle guerre, non posso comunque non pensare alla nostra economia di mercato, alle nostre crisi, ai tanti africani e magrebini che ho visto nelle metropolitane parigine e nelle sue periferie esistenziali, economiche e culturali.
Tornando da Parigi da una scuola estiva sull’Economia di Comunione, volando sui cieli d’Europa penso al nostro capitalismo. Forse perché in Francia è appena cambiato il ministro dell’economia, forse perché ho appena salutato cinquanta giovani affascinati da un’economia più fraterna e inclusiva, o perché il cuore va ai troppi aerei sbagliati che volano sulle tante terre martoriate dalle guerre, non posso comunque non pensare alla nostra economia di mercato, alle nostre crisi, ai tanti africani e magrebini che ho visto nelle metropolitane parigine e nelle sue periferie esistenziali, economiche e culturali.  disagio su questo volo mentre ripenso con un po’ di nostalgia ai giovani di vari paesi del mondo che ho appena lasciato.
disagio su questo volo mentre ripenso con un po’ di nostalgia ai giovani di vari paesi del mondo che ho appena lasciato. Il quadro del rapporto Istat non è felice, e ci vuole molta speranza civile (grande virtù di questi tempi difficili) per non scoraggiarsi e continuare la lotta.
Il quadro del rapporto Istat non è felice, e ci vuole molta speranza civile (grande virtù di questi tempi difficili) per non scoraggiarsi e continuare la lotta. Stando a quanto dicono i media, il principale obiettivo della nostra politica economica è riportare il Pil in zona positiva. Rilanciare la crescita. Troppi pochi, purtroppo, formulano invece una semplice domanda: siamo sicuri che aumentare il Pil, o la crescita, sia sempre e in ogni caso qualcosa di positivo e auspicabile? Il tasso di crescita del Pil dice troppo poco sul benessere, sulla qualità della vita, sulla democrazia, sui diritti e la libertà di una nazione. È sempre stato così, e i grandi economisti lo sapevano, e lo sanno. Ma nella nostra società la capacità di “parlare” del Pil si è ulteriormente indebolita, sebbene i dibattiti pubblici non lo sappiano, o facciano finta di non saperlo.
Stando a quanto dicono i media, il principale obiettivo della nostra politica economica è riportare il Pil in zona positiva. Rilanciare la crescita. Troppi pochi, purtroppo, formulano invece una semplice domanda: siamo sicuri che aumentare il Pil, o la crescita, sia sempre e in ogni caso qualcosa di positivo e auspicabile? Il tasso di crescita del Pil dice troppo poco sul benessere, sulla qualità della vita, sulla democrazia, sui diritti e la libertà di una nazione. È sempre stato così, e i grandi economisti lo sapevano, e lo sanno. Ma nella nostra società la capacità di “parlare” del Pil si è ulteriormente indebolita, sebbene i dibattiti pubblici non lo sappiano, o facciano finta di non saperlo. Accanto ad una profonda crisi economica l’era della globalizzazione sta rivelando sempre più una profonda crisi anche della politica. La politica, lo sappiamo, ha tra i suoi scopi principali quello di fare sintesi dopo l’analisi, arrivare all’uno dopo il molteplice.
Accanto ad una profonda crisi economica l’era della globalizzazione sta rivelando sempre più una profonda crisi anche della politica. La politica, lo sappiamo, ha tra i suoi scopi principali quello di fare sintesi dopo l’analisi, arrivare all’uno dopo il molteplice. Una delle costanti che si ritrovano nei passaggi epocali è l’invecchiamento velocissimo di parole che erano state centrali nell’epoca precedente.
Una delle costanti che si ritrovano nei passaggi epocali è l’invecchiamento velocissimo di parole che erano state centrali nell’epoca precedente.  Un mercato che esclude nega la sua vocazione etica e la sua storia: richiamarlo all'inclusione e alla comunione è una grande operazione di carità civile a vantaggio di tutti.
Un mercato che esclude nega la sua vocazione etica e la sua storia: richiamarlo all'inclusione e alla comunione è una grande operazione di carità civile a vantaggio di tutti. C’è una ideologia molto pericolosa che sta guadagnando progressivamente terreno nel nostro sistema socio-economico. È l’idea che per finanziare le attività sociali (o il “no profit”) occorra utilizzare parte dei proventi di imprese che gestiscono attività socialmente dannose, tra le quali il gioco d’azzardo.
C’è una ideologia molto pericolosa che sta guadagnando progressivamente terreno nel nostro sistema socio-economico. È l’idea che per finanziare le attività sociali (o il “no profit”) occorra utilizzare parte dei proventi di imprese che gestiscono attività socialmente dannose, tra le quali il gioco d’azzardo. In questa fase in cui l’Italia e buona parte dei Paesi dell’Europa del Sud stanno cercando di trovare vie di uscita possibili alla loro crisi economica e civile, può essere utile ricordare due princìpi-messaggi che sono alla base della scienza economica moderna. E ci provengono proprio da colui che è considerato il capostipite degli economisti moderni, lo scozzese Adam Smith, spesso evocato, erroneamente, come il paladino del capitalismo speculativo.
In questa fase in cui l’Italia e buona parte dei Paesi dell’Europa del Sud stanno cercando di trovare vie di uscita possibili alla loro crisi economica e civile, può essere utile ricordare due princìpi-messaggi che sono alla base della scienza economica moderna. E ci provengono proprio da colui che è considerato il capostipite degli economisti moderni, lo scozzese Adam Smith, spesso evocato, erroneamente, come il paladino del capitalismo speculativo. Una delle lezioni che dovremmo trarre da questa crisi, che si prospetta sempre più seria e lunga, riguarda le professioni economiche. In medicina da tempi remoti esiste il cosiddetto “Giuramento di Ippocrate”, che viene prestato dai medici e odontoiatri prima di iniziare la loro professione.
Una delle lezioni che dovremmo trarre da questa crisi, che si prospetta sempre più seria e lunga, riguarda le professioni economiche. In medicina da tempi remoti esiste il cosiddetto “Giuramento di Ippocrate”, che viene prestato dai medici e odontoiatri prima di iniziare la loro professione. È passato poco tempo da quando Le Monde (2 aprile) ha riportato la notizia di un appello di un gruppo di studenti di economia (
È passato poco tempo da quando Le Monde (2 aprile) ha riportato la notizia di un appello di un gruppo di studenti di economia ( Amore è forse la parola più abusata e logora nella nostra cultura dei consumi, della finanza e dell'edonismo. Amore è stata invece la parola che Benedetto XVI ha messo al centro della sua dottrina sociale. Deus Caritas est, la sua prima enciclica, Caritas in Veritate, l'ultima.
Amore è forse la parola più abusata e logora nella nostra cultura dei consumi, della finanza e dell'edonismo. Amore è stata invece la parola che Benedetto XVI ha messo al centro della sua dottrina sociale. Deus Caritas est, la sua prima enciclica, Caritas in Veritate, l'ultima.