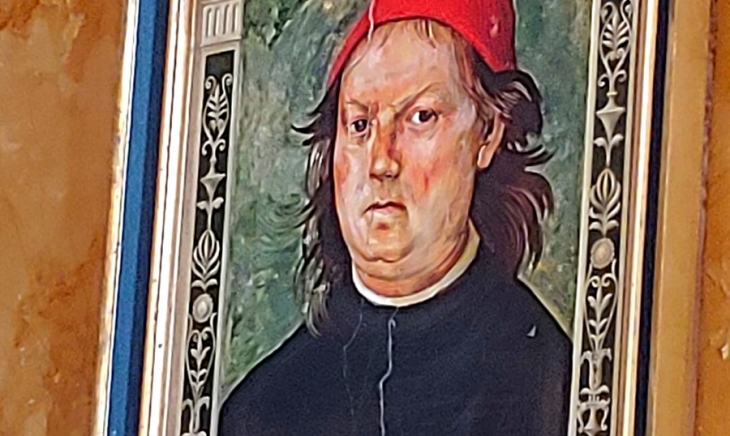Commenti - Dopo le Olimpiadi
di Luigino Bruni
pubblicato su Avvenire il 26/08/2016
Le Olimpiadi non sono un evento sportivo come tutti gli altri. Non lo sono mai state. Non sono i campionati mondiali di calcio, non sono Wimbledon, non sono il Tour de France. Non sono questo; o almeno non lo erano, perché in questa trentunesima edizione di Rio de Janeiro (tra l’altro ottima per molte cose), è iniziato, o quantomeno decollato, un tentativo di loro assimilazione allo sportbusiness dell’attuale capitalismo. In una società sempre più orientata al mercato, per lungo tempo le Olimpiadi sono state una zona franca protetta dalla logica del profitto. Il tennis, il calcio, il ciclismo, il basket, il golf – cioè, appunto – gli sport più 'di mercato', non erano gli eventi più importanti, perché le Olimpiadi erano altro.
Il business è stato sempre molto importante (basta vedere il medagliere che corrisponde quasi perfettamente al G8 o G20), ma è stato a lungo inserito all’interno di simboli e di valori diversi e più grandi. Il rapporto tra mercato e sport è particolarmente importante e delicato. Lo sport è un ambito che confina con il mercato, al punto da rischiare di non vedere la profonda diversità che esiste tra queste due sfere della vita. Nello sport e nel mercato capitalistico si compete, c’è bisogno di innovazione, di eccellenza, si può barare e si può essere leali. E così molti, dimenticando le differenze radicali, fanno il grave errore di usare metafore e linguaggio sportivi per descrivere imprese e mercati – e viceversa. Una differenza tocca la stessa natura dello sport: l’eccellenza sportiva non si misura sulla base delle vittorie, ma sulla fedeltà ai valori e ai princìpi dello sport. Un atleta può essere eccellente anche se non è vincente (se, ad esempio, gareggia nei cento metri insieme a Bolt). Non è il risultato il primo indicatore dell’eccellenza di uno sportivo.
La vittoria è certamente importante, anche perché è un segnale di virtù (quando lo sportivo, il sistema e i concorrenti sono leali) che genera imitazione, innovazioni, migliori prestazioni, record. Vincere non è il fine dello sport, il telos avrebbero detto i greci. La medaglia olimpica non è un incentivo: è un premio, cioè un segnale che riconosce e rafforza la virtù-eccellenza di uno sportivo, che attiva le dimensioni della emulazione virtuosa. E quando la medaglia da premio si trasforma in incentivo, è lo sport che diventa un’altra cosa, e non migliore. È qui che si fonda l’etica originaria delle olimpiadi moderne, che sono il paradigma della pratica sportiva. Quando, allora, il mercato capitalistico prende in mano lo sport, produce inevitabilmente un cambiamento e una deformazione profonda della sua natura, perché agisce sullo scopo, sulla ragione d’essere di questa pratica, sul suo telos, e presto sulla motivazione degli sportivi, quelli in attività e ancor di più sui futuri campioni, che saranno sempre meno interessati ai premi e sempre più agli incentivi. Tutto ciò è una faccenda seria, che non ha nulla a che fare con il romanticismo nostalgico dei bei tempi passati.
Qualcuno può anche essere soddisfatto di questa mercatizzazione dello sport (come lo è di altri giochi, della scuola, della sanità), tutti però dobbiamo essere coscienti che la posta in ballo è molto alta. Tornando a Rio, sono stati molti i segnali che anche le Olimpiadi stanno subendo (o hanno già subito) una mutazione genetica. A partire dal braciere olimpico collocato nel Maracanã, mitico tempio del calcio, e non nello stadio dell’atletica, uno stadio di calcio che è stato molto più frequentato delle piscine, delle palestre e delle piste da atletica, e forse non solo perché eravamo in Brasile. Un altro segnale è stata la crescente spettacolarizzazione degli eventi sportivi. Alcuni regolamenti (nel tiro, per esempio) sono stati modificati al fine di renderli più televisivi ed exciting, ignorando le proteste degli atleti che si sentivano trattati come circensi e giocolieri cose ottime, tra l’altro, ma nel loro contesto. Impressionante poi la metamorfosi delle cerimonie di premiazione, dove abbiamo assistito a toni, urla, musiche, dj sempre più simili a quelli inventati prima nel football americano e poi negli ultimi anni importati negli stadi di calcio.
Sono stati, poi, riammessi molti atleti professionisti, anche nella boxe. E non ultima è arrivata la discutibilissima idea di reintrodurre il golf che – massima beffa – non ha visto la partecipazione dei giocatori più famosi, sensibili a ben altri incentivi. Ma il segnale più preoccupante è arrivato proprio dalla nostra Italia. Il tradizionale colore azzurro delle nostre divise olimpioniche è stato interamente mangiato da un gigantesco numero 7 (bianco su sfondo nero) dello sponsor. L’inno nazionale delle nostre (molte) medaglie è diventato di fatto una colonna sonora di quella azienda. Non è stata davvero una grande presentazione per candidatura di Roma per il 2024. In sostanza, quella sottile ma chiara linea che separa lo sport-business dallo sport-e-basta sta diventando invisibile, perché il mercato capitalistico non può conoscere quella gratuità che è la natura più profonda dello sport, almeno di quello olimpico. Ora il test definitivo sarà rappresentato dalle Quindicesime Paralimpiadi, le Olimpiadi delle 'abilità differenti', che rischiano di pagare le difficoltà finanziare generate dalle sorelle maggiori (di cui condividono il budget) nelle quali gli affari li hanno fatti soggetti diversi dagli organizzatori. A partire dal 7 settembre lì vedremo – dalla presenza degli spettatori all’attenzione dei media – cosa resta dello spirito olimpico, se un suo ultimo soffio è ancora libero di volare senza le zavorre del business.