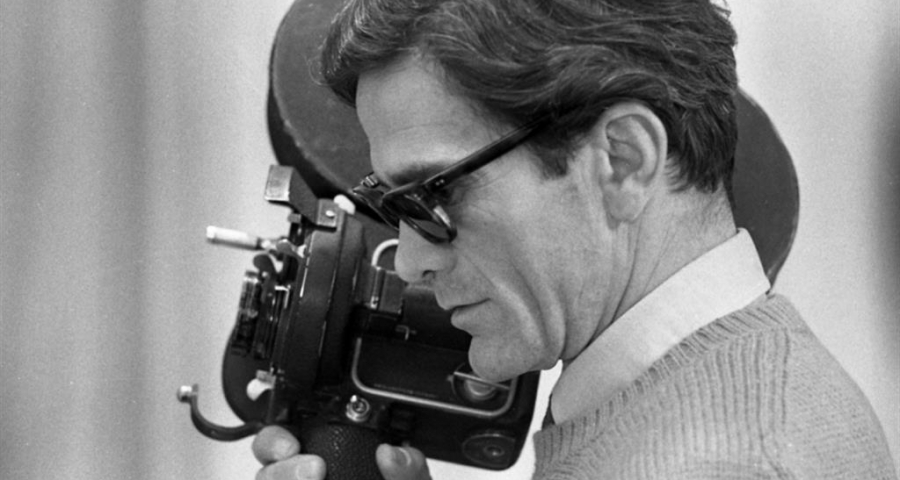Editoriali - Nel centenario della nascita, da riprendere il lascito dell’artista che seppe segnalare l’idolatria del nostro tempo
di Luigino Bruni
pubblicato su Avvenire il 05/03/2022
I poeti sono i custodi delle parole – delle loro parole, delle nostre parole di oggi, delle parole di domani. Per questo somigliano molto ai profeti biblici, sentinelle – shomerim – di una parola diversa, che custodiscono affinché le nostre parole non diventino tutte vanitas, soffio, vento, fumo, chiacchiere. Non capiamo la critica radicale di Pier Paolo Pasolini al capitalismo e al consumo senza partire dalla sua riflessione sulla lingua. Lui la vedeva ormai asservita al Potere del consumo, trasformata in un linguaggio che aveva perso contatto con le cose concrete e vive e, quindi, con l’anima del popolo e delle persone. Il destino della lingua gli svelava quello della cultura italiana – e se avesse potuto guardare il mondo un po’ più a lungo vi avrebbe letto anche il destino dell’Occidente, perché si trattava e si tratta dello stesso declino. Si allontanavano entrambe, Italia e lingua, da qualcosa di povero, duro, severo ma vero, da un mondo «puramente umano, accoratamente umano» ( Le ceneri di Gramsci, p. 45), e si avvicinavano a un nuovo mondo meno povero, duro, severo ma che diventavano ogni giorno meno vero. Il discorso di Pasolini sulla lingua è dentro la sua ricerca vitale di un fondamento non-finto, di un’origine, di una pietra angolare dell’esistenza che la trattenesse dallo sprofondare nel nulla.
Mio nonno Domenico, contadino e spaccapietre nella cava di travertino, quando parlava nel suo dialetto ascolano ci incantava tutti con le parole della sua lingua madre. Con quel lessico arcaico faceva parlare le sue emozioni più profonde, chiamava per nome la vita sua e quella degli altri, viveva tra le cose e sapeva come nominarle. Gli rispondevano il dolore, l’amore, la pietà, Dio, i dèmoni, e lui li capiva; e con essi imbastiva un dialogo intenso e vero, ogni giorno – la prima preghiera, e l’ultima, si recitano bene solo in dialetto. Ma non appena doveva parlare in italiano, la sua lingua si immiseriva, diventava insicuro e impacciato, si vergognava, era meno bello, perdeva dignità. Col passare del tempo il ricordo vivo di questa forma di violenza mi appare sempre più ingiusta e sbagliata, la sua memoria mi fa soffrire. E finalmente capisco Pasolini: «Quando saranno morti tutti i contadini e tutti gli artigiani... allora la nostra storia sarà fi- nita» (dal film La rabbia, 1963). E capisco, forse, anche la sua critica al capitalismo: «L’italiano diventa la lingua delle aziende, del mercato» (Interviste corsare, p. 216) – chissà cosa direbbe del finto inglese che è subentrato a quell’italiano? Capisco la sua lode per il lavoro artigiano, che è l’opposto della nostalgia: è un urlo per salvare le cose e la loro verità, perché togliendo le mani umane dalle cose queste vengono manipolate da una ideologia senza carne e sangue. L’artigiano e il dialetto non sono in Pasolini età dell’oro perduta e da rimpiangere, ma terra promessa ancora da raggiungere. La tv diventa il primo agente della 'strumentalizzazione' della lingua (Empirismo eretico, p. 19), perché «è attraverso lo spirito della televisione che si manifesta in concreto lo spirito del nuovo potere» (Scritti corsari, p. 24).
La critica che Pasolini fa del capitalismo (e quindi della modernità) non è meno grande e profonda delle grandissime critiche di Walter Benjamin, di Pavel Florenskij, di Ernesto de Martino o di Gramsci e Marx. Perché Pasolini capisce che il capitalismo si apre e si lascia decifrare se lo leggiamo come fatto antropologico e teologico e non solo come economia. In particolare, Pasolini intuisce che la svolta decisiva della cultura capitalista era avvenuta con l’arrivo del consumo di massa. Fino a quando il capitalismo era rimasto centrato sull’impresa e sul lavoro, lo spirito italiano, cattolico, comunitario e mediterraneo non ne era rimasto incantato e catturato. Perché sotto le Alpi il lavoro è sempre stato soprattutto fatica, travaglio, non vocazione (beruf) né tantomeno benedizione ed elezione divina. Si lavorava per destino, perché si doveva lavorare, per mangiare, per far vivere meglio i figli, e se si poteva campare senza lavorare tanto meglio. Il cambiamento epocale è avvenuto nella seconda metà del Novecento, quando l’asse del capitalismo si spostò dalla produzione al consumo, un cambiamento che ha conquistato velocemente e totalmente l’Italia (e i Paesi cattolici).
Continua la lettura su Avvenire