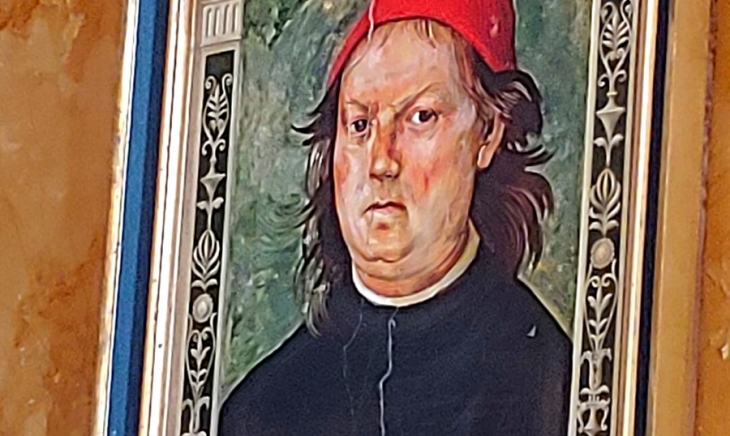Commenti - Sfida all’offshore: dura e necessaria
di Luigino Bruni
pubblicato su Avvenire il 23/06/2013

L’annuncio del G8 di lanciare una guerra ai ‘paradisi fiscali’, e le proteste dei brasiliani per la Coppa del mondo di calcio, sono fatti profondamente legati tra di loro. Il “grande” calcio ha perso contatto con il buon gioco. Tra il mercato delle multinazionali dello sport e la partita di calcio nel campetto c’è sempre meno in comune, come c’è sempre meno contatto etico tra il mio comprare pane al mercato e le dinamiche dei grandi mercati internazionali dei cereali. Non si tratta più – come fino pochi decenni fa – di differenze di grado, bensì di natura, una trasformazione profonda cui ha contribuito, e non poco, l’avvento del capitalismo finanziario.
È anche (non solo) questa trasformazione di natura di un calcio preda dei grandi interessi economici, che porta molti brasiliani a protestare in questi giorni contro l’organizzazione della Coppa. Quei brasiliani stanno allora cercando di dire qualcosa di molto importante al loro governo: investiamo le risorse nell’istruzione dei giovani, nella sanità, nella sicurezza, e quindi nella lotta alla diseguaglianza, la loro vera piaga, che la Coppa (2014) e le Olimpiadi (2016) non curano di certo.
Non si crea panem con i circenses, soprattutto quando i circenses (giochi) sono, ieri come oggi, strumenti in mano agli imperatori. E che quando creano pane quel pane non è buono, perché non arriva ai poveri ma va ad alimentare i banchetti degli sponsor e degli epuloni che costruiscono gli stadi. Il calcio non va usato come il nuovo oppio dei poveri e dei giovani, come a volte è accaduto, e non solo in Brasile. Servono, chiediamoci, nuovi stadi di calcio al Brasile, dove in molte sue regioni mancano ancora buoni ospedali, buone scuole e università? E servirebbero a chi? E servivano, e a chi, al Sudafrica (oggi in profonda crisi economica, dopo una breve primavera pre-2010)? Che cosa ci ha portato Italia ’90, oltre ad appalti corrotti e alla distrazione dalle vicende epocali di quel periodo storico? Per non parlare di Atene 2004. Ma, in generale, perché servono gli stadi a questo calcio capitalistico se mentre li costruisce con soldi pubblici svende lo sport alle multinazionali dei media, che fanno di tutto per venderci la partita in Tv sul divano e da soli, trasformando così lo sport da bene relazionale in merce?
Molte delle multinazionali che sponsorizzano i grandi eventi sportivi brasiliani e di tutto il mondo, sono utilizzatori di quei paradisi fiscali ai quali l’ultimo G8 ha (ri)promesso lotta senza quartiere. Le dichiarazione di guerra ai ‘paradisi’ sono uno dei rituali dei meeting dei grandi, o meglio, dei potenti della terra. Quella del G20 di Londra del 2 aprile 2009 fu una delle più solenni, annunciata come battaglia finale e decisiva alle operazioni offshore. Offshore, cioè azioni che avvengono a largo, nei mari, dove nessuno ci vede e i grandi mostri marini “guizzano e brulicano nelle acque” (Genesi), il regno di Leviathan e di Moby Dick.
Ma l’eden del capitalismo finanziario dai mari ha inondato anche i contenenti, fino alle Alpi. In Europa ci sono troppi stati, principati, repubbliche, isole, dove le imprese ottengono “incentivi” fiscali non troppo diversi da quelli offerti dalle famigerate isole Cayman. I loro abitanti sono moltissime imprese multinazionali, società finanziarie, banche, che con la mano impura pongono la sede legale nei paradisi, e con quella pura producono ‘bilanci sociali’ patinati, e magari generose fondazioni filantropiche con l’1% di quei profitti sbagliati. Lo scorso anno smisi di acquistare un prodotto alimentare, che pure mi piaceva molto, dopo un convegno a Montecarlo in cui scoprii che quella nostra impresa aveva lì la sede fiscale. Dovremmo avere il coraggio di riconoscere che il nostro capitalismo finanziario ha un bisogno vitale dei paradisi fiscali. L’offerta di tasse paradisiache è la risposta alla forte domanda di banche, fondi, imprese e cittadini. Una quota impressionante del commercio internazionale, circa la metà, ricorre direttamente o indirettamente ai paradisi fiscali. Quasi tutte le grandi imprese, per non parlare delle banche o dei fondi d’investimento, hanno interi dipartimenti dedicati all’ottimizzazione fiscale (espressione suggestiva), e pagano milioni di euro a consulenti tributari per trovare il prodotto fiscale migliore sui mercati/mari globali.
La politica mondiale, anche se credesse in quanto dichiara, non ha la forza per gestire questo capitalismo, per domare il Leviathan. I paradisi fiscali non sono allora un’anomalia del nostro sistema. Finché la cultura del capitalismo finanziario resterà basata sulla massimizzazione dei profitti a brevissimo termine, i paradisi fiscali saranno organici al sistema. Se volessimo veramente eliminarli dovremmo fare cose molto serie e radicali, a cominciare con stili di vita non consumistici e solidali che andrebbero inseriti nei programmi di ogni scuola, passando per la regolamentazione bancaria che invece stanno andando nella direzione opposta (es. Basilea 3), per arrivare a qualche segnale di dietro-marcia nel processo di globalizzazione ridando più poteri ai territori. In mancanza di cose serie e quindi impopolari, i nostri leader con le loro dichiarazioni continuano a comportarsi come quel mio amico che alla fine di cene con ogni sorta di grassi e dolci prendeva sempre il caffè con il dolcificante perché voleva “iniziare una dieta”. I processi seri di cambiamento s’interrogano sulle cause, e da lì partono.
Oggi, anche se è scomodo dirlo, i paradisi fiscali sono l’altra faccia, quella meno presentabile, degli smartphone, delle beauty farm, del turismo esotico, e di molte merci che di questo capitalismo piacciono tanto. Molte civiltà del passato hanno avuto i loro paradisi fiscali, quei luoghi fuori dal controllo civile, dove ci si permettevano operazioni di compensazione umana ed etica delle mille ingiustizie di ogni età. Schiavi, servi, colonie, guerre. Ma, non dimentichiamolo, ogni civiltà ha anche lottato per eliminare i grandi mostri che sguizzano nei mari. Ha voluto e sognato un mondo diverso, e ha saputo sperare: “Il Signore, visiterà Leviathan, il serpente guizzante, Leviathan, il serpente tortuoso, e ucciderà il mostro che è nel mare” (Isaia).
Oggi li chiamano “paradisi”, ma restano sempre luoghi popolati dai mostri marini non meno disumani di quelli delle civiltà passate. Non dimentichiamo che tra le vittime degli abitanti dell’offshore ci sono le piccole e medie imprese che non hanno ‘santi’ in quei paradisi, perché non hanno né la cultura (grazie a Dio) né i soldi per quelle operazioni, ma che si trovano spesso a competere con quelle imprese paradisiache. Perdono mercati, chiudono, e perdiamo lavoro. Prendiamo allora sul serio le proteste civili dei brasiliani, e non smettiamo di sdegnarci per questo capitalismo che ha bisogno degli abitanti dell’offshore. E agiamo, a tutti i livelli, per cambiarlo.
Tutti i commenti di Luigino Bruni su Avvenire sono disponibili nel menù Editoriali Avvenire