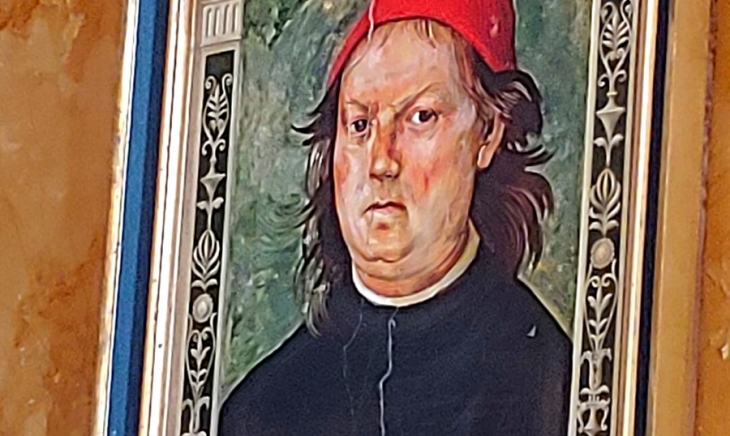Commenti - Nelle nostre vite, nello stesso tempo
di Luigino Bruni
pubblicato su Avvenire il 10/02/2013

Dobbiamo urgentemente ripensare il rapporto tra lavoro e scuola. Il lavoro è troppo assente nella formazione dei giovani. Nella società tradizionale la sua assenza era buona, per la presenza pervasiva del lavoro in tutto il resto della vita di ragazzi e giovani. Per i tanti che vivevano in campagna, il lavoro li attendeva fedele al ritorno dalla scuola, e a volte la precedeva nelle primissime ore del mattino. E anche chi viveva in città era circondato dai mestieri e dalle professioni, a partire dai giocattoli che riproducevano, per i piccoli, i lavori dei grandi. La scuola, allora, era un utile breve intervallo di non-lavoro in un mondo di lavoro (e anche duro).
Oggi ci troviamo nella situazione opposta. Il lavoro è sempre meno presente nella cultura delle nostre città, e nei giochi dei bambini, perché il suo posto lo hanno occupato la finanza, i rapporti mediati dalla rete, e soprattutto il consumo. Il tour in un supermercato, intronizzati sui carrelli della spesa, è la prima esperienza 'economica' dei nostri bambini. Manca l’amicizia tra giovani e il lavoro negli anni cruciali della formazione, e così quando poi devono iniziare a trovare o a inventarsi un lavoro, sono prima disorientati, poi spesso disoccupati.
Ma sarebbe troppo difficile permettere che i nostri studenti, durante le scuole superiori (almeno negli ultimi anni), possano svolgere forme di attività lavorativa alcune ore alla settimana, o nei lunghi mesi estivi di non-scuola? Il vero ostacolo, più forte dei problemi organizzativi o della sicurezza (l’insicurezza massima oggi si trova nei cortili dei nostri licei) va rintracciata nell’idea, ancora molto radicata, che il lavoro manuale non si addica alla formazione del carattere, perché la buona educazione si fa con la letteratura, la storia, la matematica, e non in una bottega di un artigiano, in uno studio tecnico, in una fabbrica, tantomeno in una fattoria agricola. Non ci siamo ancora liberati, nonostante San Benedetto e l’Umanesimo civile, dell’idea volgare che il lavoro manuale è impuro, adatto a servi e schiavi. L’inimicizia tra lavoro e giovani continua poi nell’Università, quando il lavoro resta ancora esperienza molto marginale, e troppo sullo sfondo. Molti studenti universitari oggi fanno 'lavoretti' per mantenersi, ma pochi iniziano da studenti il mestiere che vorrebbero fare dopo la laurea. Nei decenni passati, quando l’economia correva e cresceva (forse troppo), poteva avere un senso studiare fino a 24-25 anni, e iniziare a lavorare dopo la laurea. Ma oggi, con una economia bloccata (e che lo resterà ancora per un bel po’), se un giovane si ferma quattro o più anni preparandosi per lavorare domani, è fin troppo probabile che l’economia e la società non avranno nel frattempo creato le condizioni perché quel lavoro domani esista veramente.
Un significato vero di economie e società in recessione è anche questo: la generazione presente non crea opportunità di lavoro per i giovani, ma le distrugge. In altre parole, se oggi un giovane non entra nel mondo del lavoro durante gli anni della formazione universitaria, rischia di non entrarci mai, o di entrarci tardi e a condizioni troppo sfavorevoli, perché mentre lei o lui studiano senza già lavorare, nessun altro sta creando opportunità di lavoro per loro. Occorre allora fare in modo che gli anni di studio nell’università non siano solo preparazione al lavoro che arriverà (forse) dopo, ma siano già lavoro, non 'lavoretti' ma vero lavoro mentre si studia.
Tutto ciò significa, me ne rendo conto, andare contro la tendenza in atto negli ultimi decenni di ridurre e formattare i percorsi di studio, perché si considera la formazione come una sorta di merce che si paga oggi per lavorare meglio domani. Dobbiamo, invece, immaginare corsi di studio molto più flessibili, che affianchino, non sostituiscano, il lavoro, e che possano durare anche molti anni, perché l’obiettivo non è il pezzo di carta, ma la conoscenza e l’apprendimento, che sono alimentati anche dal lavoro, soprattutto in una società complessa come la nostra.
Ogni lavoro si impara facendolo, non a scuola, tantomeno nelle business school e con i loro master. Tutto ciò ha importanti conseguenze anche per il mondo del lavoro. Mia madre ha dovuto terminare i suoi studi alla quinta elementare, ma quei cinque anni di scuola sono cresciuti con lei, sono stati un patrimonio custodito gelosamente e fatto fruttare, e hanno accompagnato e formato la vita sua e di noi figli. Oggi invece molti dati dicono che il mondo del lavoro distrugge in pochi anni buona parte del capitale di conoscenze con cui una persona termina gli studi. Si è molto più ignoranti dopo dieci anni di lavoro che al termine dell’università, perché abbiamo costruito una civiltà del lavoro che considera gli studi come strumenti che si acquisiscono in una fase determinata della vita (giovinezza), in vista di un mondo del lavoro (adulto) che è altra cosa rispetto alla scuola e agli studi.
Tutto ciò è particolarmente vero nelle grandi imprese, che prendono bravi neolaureati, li immettono in ritmi di lavoro impossibili, non lasciano loro tempo e spazi per coltivare la loro umanità né fuori, né, tantomeno, dentro l’impresa, producendo così persone a una sola dimensione, e che anche quando studiano lo fanno per aggiornarsi e per aumentare la performance, perdendo così la cosa più vera dello studio: la gratuità. Dobbiamo riumanizzare i luoghi del lavoro postmoderni, riempiendoli di cultura, di arte, di bellezza, di gratuità, ambienti dove le persone possano fiorire in tutte le dimensioni mentre lavorano, e possano trovare il tempo per studiare cose belle e difficili anche a 40 o 50 anni, e così non si arrivi alla pensione sfiniti e persino ignoranti. Ma occorre portare più lavoro negli studi, e più studio nel lavoro.
Tutti i commenti di Luigino Bruni su Avvenire sono disponibili nel menù Editoriali Avvenire