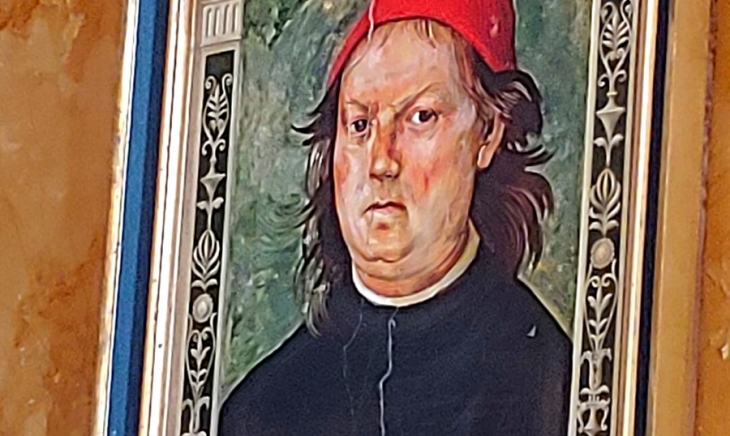Commenti - Il lavoro e le lenti sbagliate
di Luigino Bruni
pubblicato su Avvenire il 01/04/2012
 Di lavoro si discute molto, ma ci si sofferma troppo, se non esclusivamente, sui suoi aggettivi: precario, dipendente, autonomo, nero, eccetera. Mentre è elusa la domanda decisiva: che cosa è il lavoro? Eppure senza tentare di rispondere a questa domanda si resta solo sulla superficie del "fatto tutto umano" del lavoro, terminando così il discorso proprio sull’uscio dei suoi luoghi più rilevanti. Innanzitutto, dovremmo ricordarci che il lavoro è sempre attività spirituale, perché prima e dietro una qualsiasi attività lavorativa, da una lezione universitaria alla pulizia di un bagno, c’è un atto intenzionale di libertà, che è ciò che fa la differenza tra un lavoro ben fatto e un lavoro fatto male. Ed è quindi attività umana altissima in ogni contesto nel quale si compie.
Di lavoro si discute molto, ma ci si sofferma troppo, se non esclusivamente, sui suoi aggettivi: precario, dipendente, autonomo, nero, eccetera. Mentre è elusa la domanda decisiva: che cosa è il lavoro? Eppure senza tentare di rispondere a questa domanda si resta solo sulla superficie del "fatto tutto umano" del lavoro, terminando così il discorso proprio sull’uscio dei suoi luoghi più rilevanti. Innanzitutto, dovremmo ricordarci che il lavoro è sempre attività spirituale, perché prima e dietro una qualsiasi attività lavorativa, da una lezione universitaria alla pulizia di un bagno, c’è un atto intenzionale di libertà, che è ciò che fa la differenza tra un lavoro ben fatto e un lavoro fatto male. Ed è quindi attività umana altissima in ogni contesto nel quale si compie.
Persino, e paradossalmente, in un lager, come ricordava Primo Levi in una sua memoria molto nota: «Ma ad Auschwitz ho notato spesso un fenomeno curioso: il bisogno del "lavoro ben fatto" è talmente radicato da spingere a far bene anche il lavoro imposto, schiavistico. Il muratore italiano che mi ha salvato la vita, portandomi cibo di nascosto per sei mesi, detestava i nazisti, il loro cibo, la loro lingua, la loro guerra; ma quando lo mettevano a tirar su muri, li faceva dritti e solidi, non per obbedienza ma per dignità professionale».
Sono proprio la "dignità professionale" e il "bisogno del lavoro ben fatto" che si stanno progressivamente e inesorabilmente allontanando dall’orizzonte della nostra civiltà, che era stata invece fondata eminentemente su quei pilastri. L’etica delle virtù, che ha dato vita nei secoli anche all’etica delle professioni e dei mestieri, si basava su una regola aurea, una vera e propria pietra angolare dell’intera fabbrica civile: la prima motivazione del lavoro ben fatto si trova nella dignità professionale stessa.
La risposta alla ipotetica domanda: «Perché questo tavolo o questa visita medica vanno fatti bene?» era, in una tale cultura, tutta interna, intrinseca, a quel lavoro e a quella determinata comunità o pratica professionale. La necessaria e importante ricompensa, monetaria o di altro tipo, che si riceveva in contraccambio di quella opera, non era – e qui sta il punto – la motivazione del lavoro ben fatto, ma era solo una dimensione, certamente importante e co-essenziale, che si poneva su di un altro piano: era, in un certo senso, un premio o un riconoscimento che quel lavoro era stato fatto bene, non il suo "perché".
La cultura economica capitalistica dominante, e la sua teoria economica, sta operando su questo fronte una rivoluzione silenziosa, ma di portata epocale: il denaro diventa il principale o unico "perché", la motivazione dell’impegno nel lavoro, della sua qualità e quantità. Tutta la teoria economica del personale, che si basa esattamente su questa ipotesi antropologica, sta producendo lavoratori sempre più simili alla teoria.
È questa la cultura dell’incentivo, che si sta estendendo anche ad ambiti tradizionalmente non economici, come la sanità e la scuola, dove è divenuto normale pensare, e agire di conseguenza, che un maestro o un medico diventano buoni (eccellenti), solo se e solo in quanto adeguatamente remunerati e/o controllati. Peccato che una tale antropologia, parsimoniosa e quindi errata, sta producendo il triste risultato di riavvicinare sempre più il lavoro umano alla servitù se non alla schiavitù antica, perché chi paga non compra solo le prestazioni, ma anche le motivazioni delle persone e quindi la loro libertà. E dopo oltre un secolo e mezzo in cui abbiamo combattuto battaglie epocali di civiltà per la difesa dei diritti dei lavoratori dalla loro mercificazione e asservimento, oggi restiamo silenti e inermi di fronte al capitalismo contemporaneo che nel silenzio ideologico sta riducendo veramente il lavoro a merce, e non solo quello degli operai ma anche dei manager, sempre più proprietà delle imprese che li pagano, e li comprano.
Il disagio del mondo del lavoro è anche il frutto del dilagare incontrastato di questa anticultura del lavoro, che non vedendo il 'bisogno del lavoro ben fatto' come la vocazione più radicale presente nelle persone, tratta i lavoratori come moderni animali domabili con bastone (sanzione-controllo) e carota (incentivo).
E se trasformiamo così i lavoratori, non dobbiamo poi stupirci se le imprese si ritrovano persone pigre, opportuniste e (o perché?) infelici. Il capitalismo, a causa degli 'occhiali antropologici' sbagliati che ha purtroppo inforcato, non capisce che quell’animale simbolico che chiamiamo homo sapiens ha bisogno di molto di più del denaro per dare il meglio di sé al lavoro, ha pensato di poterlo "addestrare" (parola oggi di nuovo troppo usata da manager e ministri) e controllare, senza ancora riuscirci del tutto.
Grazie a Dio. C’è, allora, un urgente bisogno di una nuova-antica cultura del lavoro, che, senza guardare nostalgicamente indietro guardi politicamente avanti, torni a scommettere sulle straordinarie risorse morali presenti in tutti i lavoratori, che si chiamano libertà e dignità, che non possono essere comprate, ma solo donate dal lavoratore. Risorse morali che bisogna valorizzare e alle quali bisogna saper educare, con la parola (anche quella che transita per le leggi) e con l’esempio. Senza questa nuova-antica cultura del lavoro, continueremo a discutere di articolo 18 e dintorni, ma resteremo troppo distanti dalle officine, dalle fabbriche, dagli uffici, che ancora vanno avanti perché, in barba alla teoria economica, tanti continuano a lavorare e a tirar su "muri dritti" prima di tutto per dignità professionale, anche quando non dovrebbero farlo sulla base degli incentivi monetari. Fino a quando resisteranno?
Tutti i commenti di Luigino Bruni su Avvenire sono disponibili nel menù Editoriali Avvenire