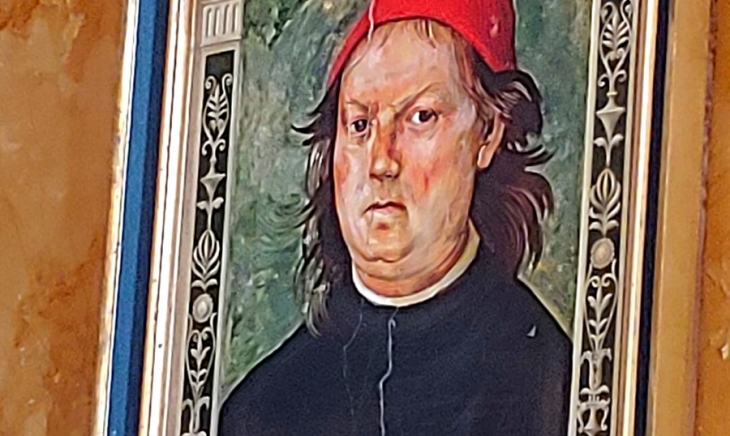Commenti - Necessaria più democrazia
di Luigino Bruni
pubblicato su Avvenire il 03/03/2013

In Svizzera oggi si sta svolgendo un referendum per porre un freno alle remunerazioni dei manager delle società quotate in borsa. È questa una felice occasione per riaprire anche da noi il tema delle remunerazioni dei cosiddetti “top manager”, e su quello, ancora più importante perché radice del primo, della democrazia economica. Ma l’Italia? L’Europa? Una ragione di questa assenza, o, speriamo, ritardo, è l’incapacità dell’Europa, tanto più dell’Italia, di proporre nei decenni passati una diversa cultura economica e di impresa.
Oggi le business school sono tutte uguali: ad Harvard, Nairobi, San Paolo, Berlino, Pechino, Milano si insegnano le stesse cose, si utilizzano gli stessi libri di testo, a volte persino le stesse slides scaricabili in rete. Ho visto fare corsi di ‘responsabilità sociale d’impresa’ in classi dove dirigenti di cooperative sedevano accanto a manager di fondi di investimento speculativi, poiché, si diceva, “business is business”. E così non stupisce, ma rattrista soltanto, che si stiano progressivamente avvicinando tra di loro la cultura e gli stipendi delle grandi cooperative e quelli delle imprese capitalistiche, un avvicinamento che farà senz’altro rivoltare nella tomba i fondatori del movimento cooperativo, che avevano immaginato e realizzato imprese diverse anche perché capaci di tradurre i principi di fraternità e uguaglianza in busta paga, e non solo nei preamboli degli statuti.
Eppure l’Europa e l’Italia avevano, e un po’ ce l’hanno ancora, un altro modo di fare impresa e di fare società, un altro ‘spirito del capitalismo’, che si chiamano in Germania ‘economia sociale di mercato’, in Francia ‘economia sociale’, in Italia ‘economia civile’, in Spagna e in Portogallo ‘economia solidaria’. Una cooperativa sociale non è una istituzione filantropica (charity), ma una faccenda di reciprocità e di inclusione produttiva, è un “fare con” prima di essere un “fare per”. Una fondazione bancaria non è una foundation americana, e le piccole e medie imprese di natura famigliare, l’asse portante della nostra economia, non hanno né la cultura né gli strumenti della corporation anonima, anche se tante di queste nostre imprese si sono smarrite per inseguire quei modelli estranei. In Italia avevamo anche la gloriosa tradizione della Economia aziendale, oggi purtroppo in via d’estinzione, che era un felice tentativo di tradurre il modello comunitario e relazionale italiano in cultura organizzativa, dove lo scopo dell’azienda non era la massimizzazione del profitto, ma l’equilibrio tra tutte le componenti di una istituzione, e il cui principio fondante era “il soddisfacimento dei bisogni umani” (Gino Zappa, 1927).
La crisi economica è anche frutto di una cultura manageriale che si è rivelata inadeguata, certamente per una legislazione insufficiente e sbagliata, ma anche per una forma mentis che inizia nelle università di economia e poi continua nei master; una formazione sbagliata che è anche alla base della giustificazione di quei stipendi da superstar. Gli attuali curricula economici sono, in tutto il mondo, sempre più depurati da tutte le dimensioni umanistiche e storiche, illudendosi che riducendo il pensiero economico a numeri, tabelle, grafici e algoritmi (e sempre più semplici), si possa formare della gente capace di pensare, di creatività, di innovazione vera, o di coordinare le persone e il loro mistero antropologico e spirituale, che restano tali anche quando lavorano. Eppure i futuri lavori nasceranno, certamente in Italia, da cultura, arte, turismo, relazioni, e per far bene questi mestieri è molto utile conoscere la storia, la cultura o l’arte, e forse più delle tecniche di bilancio, di valutazione e controllo.
C’è allora bisogno di riaprire un dibattito pubblico su questi temi cruciali, che non possono essere lasciati agli “addetti ai lavori”: lo abbiamo fatto negli anni passati, e i risultati sono sotto gli occhi tutti. La cultura democratica moderna ha posto al centro la politica e il governo dello Stato: ottimo. Ma il mondo è molto cambiato, e oggi sappiamo, o dovremmo sapere, che il buongoverno passa anche, e sempre più, per il buongoverno dei mercati, delle imprese e delle organizzazioni. Di Parlamento ce n’è uno (in Italia), ma i consigli di amministrazione di banche e imprese sono decine di migliaia: la qualità della nostra vita, della nostra dignità e libertà dipende anche da questi, e non possiamo continuare a ignorarlo. La democrazia economica sarà la sfida del XXI secolo, se vogliamo evitare di ridurre l’area democratica a settori sempre meno rilevanti per la vita della gente, a sentirci sovrani il giorno delle elezioni e tutti gli altri giorni sudditi di tanti regnanti non democratici. Il XX secolo ha creato e ha mantenuto saldo il confine tra gli ambiti di azione della democrazia e quelli retti da altri principi non democratici.
Tra gli ambiti non democratici quello delle imprese capitalistiche era ed è il più importante e rilevante. La nuova era dei beni comuni ci costringe a ripensare profondamente il confine della democrazia, se non vogliamo perderla, o costringerla in una regione asfittica, un giorno forse irrilevante. Il mercato e le imprese non sono faccende private: non lo sono mai state (si pensi ai sindacati dei lavoratori e di chi fa impresa). Questa crisi, però, ci ha detto con estrema forza e chiarezza che anche l’economia, la finanza e il mercato sono veramente ‘cosa pubblica’, con le sue delizie e con le sue croci, di cui abbiamo il dovere e il diritto di occuparci, non fosse altro perché siamo noi a pagare tutte le conseguenze del loro malgoverno. Occorre allora inventare nuovi strumenti di democrazia economica, che non possono essere gli stessi della democrazia politica. E occorre pensarli e su scala globale. Ma occorre farlo presto, è troppo importante.
Tutti i commenti di Luigino Bruni su Avvenire sono disponibili nel menù Editoriali Avvenire