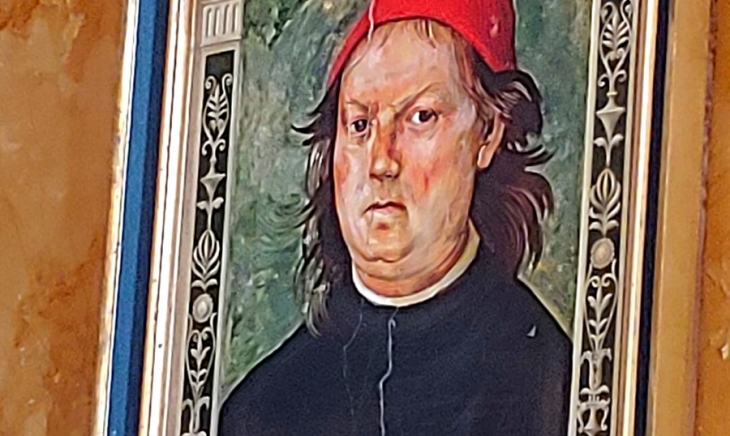Commenti - Le virtù da ritrovare e vivere/7
di Luigino Bruni
pubblicato su Avvenire il 22/09/2013
La reciprocità è la legge aurea della socialità umana. La reciprocità spiega molto più di ogni altra singola parola la grammatica fondamentale della società, anche quella dell’indignazione, delle vendette e delle interminabili cause in tribunale. Il DNA dell’animale politico è un’elica fatta dell’intreccio di dare e di ricevere. Anche l’amore umano è essenzialmente una faccenda di reciprocità, dal suo primo istante all’ultimo, quando spesso si lascia questa terra stringendo la mano di qualcuno che si ama, o, in sua assenza, stringendola dentro con le ultime energie della mente e del cuore.
Questa dimensione di reciprocità dell’amore, dove amiamo chi ci ama, le culture umane l’hanno espressa in vari modi e con molte parole. In quella greca le più note erano eros e philia, due forme di amore diverse, ma che hanno in comune la reciprocità, il bisogno fondamentale della risposta dell’altro. L’eros è una reciprocità diretta, biunivoca, esclusiva, dove l’altro viene amato perché ci colma una indigenza, ci sazia, riaccendendolo, un desiderio vitale. Nella philia greca (che assomiglia a ciò che oggi chiamiamo amicizia), la reciprocità è più articolata: si tollera la mancata risposta dell’altro, non si fanno sempre i conti di dare e di avere, e si può perdonare molte volte. Ecco perché mentre l’eros non è una virtù, la philia lo può essere, perché richiede fedeltà all’amico che, temporaneamente, tradisce e non reciproca l’amore. Ma l’amore-philia non è un amore incondizionale, perché s’interrompe quando l’altro o l’altra con la sua non-reciprocità mi fa capire che non vuole più essere mio amico.
L’eros e la philia sono essenziali e splendidi per ogni vita buona, ma non bastano. La persona è grande perché non le basta la già grande reciprocità, vuole l’infinito. Così, a un certo punto della storia, quando il tempo si fece maturo, nacque il bisogno di trovare un’altra parola per dire una dimensione dell’amore non racchiusa in quelle due semantiche dell’amore, pur già ricche e alte. Questa nuova parola fu agape, non del tutto inedita nel vocabolario greco, ma nuovi furono l’uso e il significato che le attribuirono “quelli della strada”, il primo (bellissimo) nome dei cristiani. Ma l’agape non fu un’invenzione; fu una rivelazione di una dimensione presente, in potenza, nell’essere di ogni persona, anche quando resta sepolta e aspetta qualcuno che le dica “vieni fuori”. L’agape non è una forma di amore che comincia quando finiscono le altre, non è il non-eros o la non-philia, perché è la sua presenza che rende ogni amore pieno e maturo. Perché è l’agape che dona all’amore umano quella dimensione di gratuità che non è garantita dalla philia, tanto meno dall’eros; e così, aprendole, compie tutte le virtù, che in sua assenza sono soltanto sottile egoismo. Anche per questa ragione quando i latini tradussero l’agape, scelsero charitas, che nei primi tempi era scritta con l’acca, una lettera tutt’altro che muta, perché diceva molte cose.
Innanzitutto che quella charitas non era né amor né amicitia, era qualcos’altro. Poi che quella charitas non era più la caritas dei mercanti romani, che la usavano per esprimere il valore dei beni (ciò che costa molto, che è “caro”). Ma quell’acca voleva anche ricordare che charitas rimandava anche ad una altra grande parola greca: charis, grazia, gratuità (“Ave Maria, piena di charis”). Non c’è agape senza charis, né charis senza agape. Così la philia può perdonare fino a sette volte, l’agape fino a settanta volte sette; la philia dona la tunica, l’agape anche il mantello; la philia fa un miglio con l’amico, l’agape due, e anche col non-amico. L’eros sopporta, spera, copre poco; la philia copre, sopporta, spera molto; l’agape spera, copre e sopporta tutto.
La forma d’amore dell’agape è anche una grande forza di azione e di cambiamento economico e civile. Tutte le volte che una persona agisce per il bene, e trova nell’azione stessa e dentro di sé le risorse per andare avanti anche senza reciprocità, lì è all’opera l’agape. L’agape è l’amore tipico dei fondatori, di chi dà inizio a un movimento, a una cooperativa, senza poter contare sulla reciprocità degli altri, e dove è richiesta fortezza e perseveranza nelle lunghe solitudini. L’agape non condiziona la scelta di amare alla risposta dell’altro, ma quando questa risposta manca soffre, perché l’agape è pieno nella reciprocità (<vi do un comandamento nuovo: amatevi!>), ma non sta male al punto di interrompere il suo amore non amato. La pienezza della reciprocità agapica si esprime anche in un rapporto ternario: A si dona a B, e B si dona a C, una transitività dell’agape che non è presente né nella philia, né, tantomeno, nell’eros. Anzi, questa dimensione di “terzietà” e di apertura è essenziale perché si dia agape.
Persino l’amore materno e paterno verso un figlio non sarebbe agapico, e quindi maturo e pieno, se si esaurisse nella relazione A => B, B => A, senza la dimensione B => C …, che supera ogni tentazione di amore incestuoso o narcisistico. Questo bisogno di reciprocità, l’andare avanti anche quando manca la risposta, rendono l’agape un’esperienza relazionale a un tempo vulnerabile e fertile. L’agape è una ferita fecondissima. È l’agape che rende le comunità luoghi accoglienti e inclusivi, porte spalancate e mai chiuse, che scardina gerarchie sacrali, ordini castali, e ogni tentazione di potere. L’agape poi è essenziale per ogni Bene comune, anche perché conosce un tipo di perdono che è capace di cancellare il male ricevuto. Chiunque sia stato vittima del male, di ogni male, sa che quel male fatto e ricevuto non può essere pienamente compensato né riparato dalle pene e dai risarcimenti civili. Continua a operare, è una ferita che resta lì; a meno che un giorno non incontri il perdono dell’agape che, a differenza del perdono dell’eros e della philia, ha la capacità di sanare ogni ferita, anche quelle mortali, e farla diventare l’alba di una resurrezione.
C’è però una tesi che ha attraversato la storia della nostra cultura. L’agape – si dice – non può essere una forma di amore civile, perché a causa della sua vulnerabilità non sarebbe prudente. La si potrebbe vivere soltanto nella vita familiare, spirituale, forse nel volontariato; ma nelle piazze e nelle imprese dovremmo accontentarci soltanto dei registri dell’eros (incentivi) e, al massimo, della philia. Una tesi molto radicata, anche perché si fonda anche sull’evidenza storica delle moltissime esperienze nate dall’agape e poi retrocesse alla sola gerarchia o al comunitarismo. È la storia di quelle tante comunità partite con l’agape e che di fronte alle prime ferite si sono trasformate in sistemi molto gerarchici e formalistici. O esperienze nate aperte e inclusive, e che dopo i primi fallimenti hanno chiuso le porte espellendo i diversi. La storia è anche il susseguirsi di queste “retrocessioni”, che però non riducono il valore civile dell’agape, e che dovrebbe spingerci a mettere più agape, non meno, anche nella politica, nelle imprese, nel lavoro. Perché tutte le volte che l’agape appare nella storia umana, anche quando vi resta per poco, pochissimo, tempo, non lascia mai il mondo come l’aveva trovato. Innalza per sempre la temperatura dell’umano, pianta un nuovo chiodo nella roccia, e chi domani riprenderà la scalata partirà qualche metro, o centimetro, più in alto.
Nessuna goccia d’agape sulla terra va sprecata. L’agape allarga l’orizzonte di possibilità di bene dell’umano, è il lievito e il sale di ogni pane buono. Il mondo non muore, e la vita ricomincia ogni mattina, perché ci sono persone capaci di agape: <Sono tre le cose che rimangono: la fede, la speranza, e l’agape. Più grande di tutte è l’agape>.
Tutti i commenti di Luigino Bruni su Avvenire sono disponibili nel menù Editoriali Avvenire