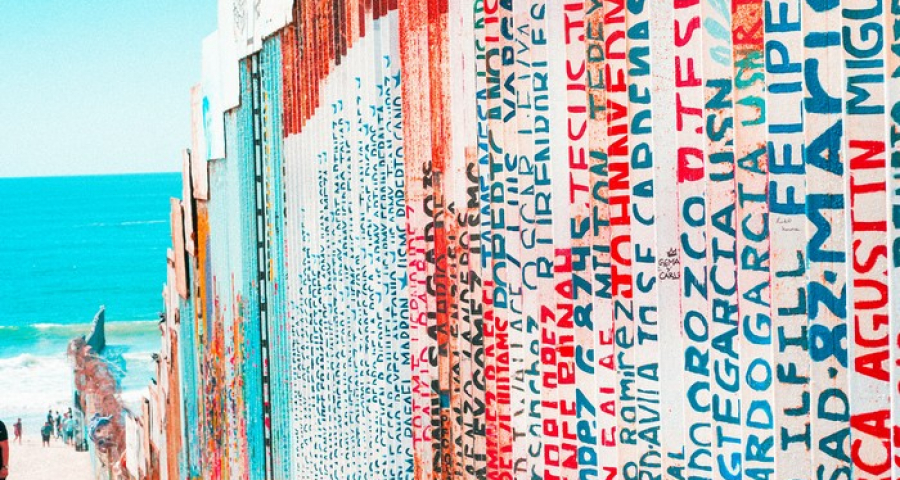Educazione finanziaria: con i più piccoli, anche per le faccende di casa, occorre usare il denaro come premio e non come incentivo
di Luigino Bruni
pubblicato su Avvenire il 03/10/2025
«Le Avventure di Pinocchio» oltre ad essere un classico della letteratura mondiale, contengono anche molta economia. I classici non invecchiano, e neanche l’etica economica di Pinocchio è invecchiata. In alcuni suoi passaggi troviamo dei veri e propri insegnamenti sull’uso del denaro dei bambini e dei ragazzi. Fin dall’inizio delle sue avventure, Pinocchio sviluppa un pessimo rapporto con il denaro che è all’origine delle pagine disgraziate della sua storia. Finisce nel teatrino di Mangiafoco vendendo il suo abbecedario, e poi, per i cinque zecchini d’oro donati, finisce tra le zampe del gatto e la volpe e del loro abuso economico.
Gli interpreti di Pinocchio, inclusi quei pochi economisti che hanno provato a studiarlo, di fronte alla impreparazione e ingenuità di Pinocchio nel maneggiare soldi, hanno tirato la conclusione che a molti appare la più ovvia: è bene che i ragazzi siano educati da subito alla finanza, alla logica del denaro, altrimenti da grandi finiranno per diventare vittime di gatti e volpi: “La storia di Pinocchio offre lo spunto per ragionare sul nostro denaro” (FEduF).
In realtà, sono convinto che il messaggio del libro di Collodi sia esattamente il contrario, e cioè: tenete lontani i vostri ragazzi e ragazze dal denaro e dalla sua logica, finché siete in tempo. Il denaro e i ragazzi vivono – dovrebbero vivere – in mondi diversi. La loro lingua madre è il dono, e quando entrano in contatto con il denaro e la logica economica occorre farlo con infinita cura perché succede troppo spesso che la forza del linguaggio economico si divori il delicato registro del dono – e questo sì che sarebbe un vero disastro educativo.
Quando hanno bisogno di denaro lo chiedono ai genitori, ed è dentro questo rapporto non economico e di gratuità che si impara anche l’abbecedario dell’economia di domani. La loro dipendenza economica dai genitori è ottima, perché il denaro conosciuto all’inizio come dono crea le premesse etiche per assegnare il giusto valore ai contratti e al lavoro, domani. C’è, ormai, evidenza empirica che bambini e pre-adolescenti (in esperimenti svolti in setting controllati) alle prese con attività rette da incentivi estrinseci (monetari o meno), durante lo sviluppo mostrano una minore attitudine a svolgere attività a ricompensa intrinseca (David Greene e Mark R. Lepper 1974).
Il principale tema al centro dell’uso del denaro con i minori è dunque il cosiddetto spiazzamento (crowding-out) motivazionale (Frey 1997; Aknin, Van de Vonderwoort and Hamlin, 2018). L’introduzione di una motivazione estrinseca all’attività stessa (il denaro) al fine di far compiere al ragazzo una data azione, progressivamente erode nei più giovani la forza delle motivazioni intrinseche a quella azione, fino al possibile esito di educare persone che rispondono solo agli incentivi esterni. Se, per un esempio, una famiglia introduce un sistema incentivante per le attività domestiche dei figli e figlie (sparecchiare: 3 euro; piatti: 3; passeggiata nonno 4; passeggiata cane 2…), col tempo diventerà molto difficile educarli all’etica delle virtù, secondo la quale la tavola va sparecchiata per una ragione interna all’essere figlio e parte di una famiglia, il nonno accompagnato perché gli si vuole bene e fa parte del “dovere” di un nipote farlo, la camera tenuta in ordine perché è bene farlo, eccetera. Questo non significa non usare mai denaro con i figli piccoli; occorre però usarlo come premio e non come incentivo, cioè per rafforzare l’azione buona e non come il “perché” fare una azione buona – il premio rafforza la virtù, non la crea; l’incentivo crea l’azione, che non ci sarebbe senza l’incentivo.
L’incentivo usato con gli adulti può svolgere la sua buona funzione se poggia su un’etica intrinseca che è capace di reggere l’impatto manipolatorio degli incentivi – non dimentichiamo che incentivo deriva da incentivus, il flauto che accordava gli strumenti, l’incantatore magico che ci porta dove non andremo spontaneamente. Se invece l’incentivo giunge su persone non dotate di una robusta etica delle virtù, si ritrovano col tempo simili ad asini che rispondono solo a bastone e carota. È la libertà, e quindi la capacità di gratuità, ad essere al centro di questi strumenti e di questi ragionamenti. Ieri era più semplice che l’incentivo poggiasse su un’etica intrinseca del “lavoro ben fatto”, oggi è sempre molto più difficile, soprattutto se viene introdotta troppo presto a casa o a scuola.
Discorso analogo, seppur diverso, è quello sulla paghetta. Anche in questi casi, sebbene lo strumento della paghetta non coincida con quello dell’incentivo (possono coesistere, o si può attivare l’uno senza l’altra e viceversa), scatta un frame contrattuale ed economico. Anche la pedagogia della paghetta porta inevitabilmente alla crescita del registro economico-finanziario e a lasciare più sullo sfondo quello della gratuità e del dono, e della buona dipendenza dalla mediazione dei genitori.
Oggi i giovani non stanno sviluppando una buona amicizia con il mondo del lavoro anche perché la logica economica entra troppo presto dentro casa, mediante il cavallo di Troia della responsabilità. La cultura dominante dell’“impero” è sempre più quella del business, e come accade in ogni impero la sua cultura entra ovunque, quasi sempre a nostra insaputa.
Credits Photo: Foto di Splenetic su Freeimages.com